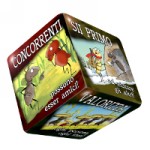Economia della gioia 3/ La cultura giubilare attraversa la Bibbia in profondità come nei due episodi cruciali del libro di Neemia
di Luigino Bruni
pubblicato su Avvenire il 08/04/2025
La cultura giubilare non va cercata soltanto nei testi che regolano espressamente il Giubileo o l’anno sabbatico. In diversi libri della Bibbia ci sono, infatti, passaggi che contengono dimensioni decisive per comprendere l’umanesimo del giubileo. Dopo l’analisi del libro di Geremia, ora guardiamo da vicino un capitolo del libro di Neemia, un alto funzionario (coppiere) della corte del re persiano Artaserse (465-424 a.c.). Neemia era un ebreo laico nato in esilio, che, come Ester, arrivò alle più alte cariche di corte, e poi divenne governatore della Giudea sotto l’occupazione persiana. Neemia, mentre si trovava a Susa, venne a conoscenza della condizione misera dei giudei di Gerusalemme: “I superstiti che sono scampati alla deportazione sono là, nella provincia, in grande miseria e desolazione; le mura di Gerusalemme sono devastate” (Ne 1,3). Neemia sentì una chiamata (cap. 2), chiese al re di essere inviato a Gerusalemme per ricostruirla. Quando, infatti, un parte degli esiliati in Babilonia tornò in patria, la convivenza con gli ebrei restati a Gerusalemme non fu facile. C’erano evidenti ragioni economiche e patrimoniali - le terre dei deportati erano, almeno in parte, passate alle famiglie rimaste e ora venivano reclamate -; ma c’erano anche ragioni teologiche e religiose: chi era scampato alla deportazione tendeva a trattare i deportati come colpevoli che avevano meritato l’esilio (operazioni molto comuni in molte comunità).
Mentre Neemia inizia a ricostruire le mura insieme alla dignità del suo popolo di Gerusalemme, il suo libro ci riporta un episodio molto importante: “Si alzò un gran lamento da parte della gente del popolo e delle loro mogli contro i loro fratelli Giudei. Alcuni dicevano: «I nostri figli e le nostre figlie sono numerosi; prendiamoci del grano per mangiare e vivere!»”. Neemia fu “molto indignato” da quanto ascoltato. E poi si rivolse ai nobili e ai magistrati: “Voi esigete dunque il pagamento di un interesse tra fratelli?”. Convocò il suo popolo e disse: “Quello che voi fate non va bene… Condoniamo questo debito! Rendete loro oggi stesso i loro campi, le loro vigne, i loro oliveti e le loro case e l'interesse del denaro del grano»”. Risposero: “Restituiremo e non esigeremo più nulla da loro”. Allora, “tutta l'assemblea disse: «Amen» e lodarono il Signore. Il popolo si attenne a questa parola” (5,1-13). Un meraviglioso amen economico e finanziario, tutto laico e tutto spiritualissimo.
Molto importante è anche il grido delle ‘mogli’ verso i maschi della comunità. Parole antiche e forti che dovrebbero farci riflettere molto su una dolorosa costante della storia umana. È la mitezza infinita e la pazienza eroica delle mogli e delle donne che nei millenni hanno subito violenze per guerre scatenate da maschi, e continuano a subirle. Una profonda e vasta sofferenza tutta femminile, impotente ed innocente, che attraversa i luoghi e tempi, tutte le culture. Un colossale patrimonio etico dell’umanità, un dolore collettivo millenario, che meriterebbe almeno il Nobel per la pace, attribuito alle donne di ieri e di oggi, che non solo hanno accudito la pace e combattuto dentro le case e nelle piazze tutte le guerre, ma sono state e sono le prime che subiscono nei loro corpi e nella loro anima le devastazioni e le atrocità di tutte le guerre. I maschi combattevano e combattono le guerre nei campi di battaglia e nelle macchine di morte, le donne le combattono nella loro carne e in quella dei loro figli e mariti: una sofferenza raddoppiata, moltiplicata, infinita. “Ho sempre in mente quanto raccontato da Teresa Mattei, la più giovane delle ventuno costituenti: quando si votò la Costituzione, più in specifico l’articolo 11 relativo al ripudio della guerra, le donne, di qualsiasi appartenenza politica fossero, si presero per mano. Ancora oggi mi emoziono quando leggo questo ricordo” (Lucia Rossi, Segreteria Spi-CGIL). Una stupenda immagine della grande e tenace alleanza di donne per la pace, per dire con il linguaggio muto del corpo e delle mani il loro ripudio assoluto della guerra. Quella splendida solidarietà tra donne che ancora sopravvive, con fatica, è maturata nei secoli durante le guerre, quando hanno imparato a custodire la vita e la speranza in un mondo di maschi che l’uccidevano mille volte con le armi, con i gesti e con le parole sbagliate - il primo potere è sempre quello del linguaggio con cui si scrivono tutti i discorsi e si controllano tutte le parole. Questo lamento e protagonismo delle donne ci rivela un'altra dimensione fondativa della cultura giubilare, che durante la storia della cristianità abbiamo dimenticato relegando le donne al ruolo di comparse nei fondali delle chiese, nei canti, negli ‘amen' liturgici, nelle code delle processioni.
Questo atto di Neemia e delle donne è allora uno degli episodi più belli della Bibbia che ci dice, tra l’altro, che il grande dolore di settant’anni di esilio babilonese non era stato sufficiente per far sì che le leggi mosaiche sul divieto di prestito a interesse diventassero una cultura diffusa tra la gente - come oggi non è sufficiente inserire qualche donna in politica per cambiare la cultura della guerra. I peccati economici continuavano anche dopo il ritorno in patria (538 a.c.). Ma dal grande trauma dell’esilio lungo i fiumi di Babilonia il popolo aveva imparato l’importanza essenziale della cultura sabbatica e quindi della remissione dei debiti e della liberazione degli schiavi. La Bibbia è anche la custode segreta e discreta di pochi gesti diversi, a volte soltanto di uno, perché noi li possiamo trasformare in seme.
Il senso pieno di questo grande episodio si apre solo se lo leggiamo insieme al capitolo otto dello stesso libro di Neemia, in uno dei brani più noti e importanti di tutta la Bibbia, che ha come protagonista il sacerdote Esdra. È un momento cruciale della rifondazione religiosa e comunitaria del popolo, di una rara forza lirica. Eccolo: “Allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla porta delle Acque e disse allo scriba Esdra di portare il libro della Legge di Mosè… Esdra portò la Legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere… Come Esdra ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani … Tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le parole della Legge” (cap. 8, 1-9). Altri amen, bellissimi - che bello sarebbe poter ripetere uno di questi ‘amen’ come nostra ultima parola su questa terra!
Questo racconto non è soltanto un punto d’origine (forse il punto) della tradizione dell’uso liturgico e comunitario della Scrittura; è anche il dono della parola, della Torah a tutto il popolo - la lettura durò molte ore, e tutti stavano in piedi. Non più monopolio degli scribi e dei sacerdoti, qui la parola diventa elemento essenziale di un nuovo patto sociale, di una resurrezione collettiva - la parola popolo è ripetuta dodici volte. E l’esilio è davvero terminato. Ci sono stati altri momenti nella storia d’Israele di trasmissione della parola. Ma la Bibbia ci ha voluto donare questo momento diverso, un atto solenne presentato con la stessa forza di un testamento, per segnare l’inizio di un tempo nuovo, che può essere il nostro tempo.
C’è poi un dettaglio importante: quell’assemblea del popolo si svolge ‘sulla piazza davanti alla porta delle Acque’. Questo evento liturgico e spirituale decisivo non si compie quindi nel tempio, a dirci che la Parola ha priorità sul tempio - va ricordato che a Gerusalemme il tempio non aveva mai smesso di funzionare. Allora in questo brano troviamo una fondazione della vera laicità biblica: la parola può essere annunciata, forse deve essere annunciata nella piazza, in mezzo alle strade della città, dove poi continua a camminare in ‘processione’ - una processione civile che ricorda le processioni che si facevano in occasione delle fondazioni dei primi Monti di Pietà nel Quattrocento. Da quel giorno sappiamo che per proclamare la parola di Dio non c’è luogo più liturgico di una strada, di una piazza, di un mercato. Con quella piazza di fronte alla porta delle Acque torna la prima piccola tenda che alle pendici del Sinai copriva l’Arca dell’alleanza con dentro le tavole della Torah. Quella tenda un giorno divenne il grande tempio di Salomone, ma nel popolo non si era mai spenta la nostalgia di quella prima tenda mobile, della sua povertà e libertà, quando ‘c’era soltanto una voce’. E sta sempre qui la radice della profezia con cui si chiude la Bibbia: nella nuova Gerusalemme “non vidi alcun tempio” (Ap 21,22), e ‘l’albero della vita’ si trovava “in mezzo alla piazza della città” (22,2).
E ora torniamo alla cultura giubilare. La nuova fondazione comunitaria liturgica, la laicità della piazza che superò la sacralità del tempio, fu preparata dal patto economico-sociale della remissione dei debiti, generato dal grido delle donne del capitolo cinque. Neemia prima ristabilì la comunione e la giustizia nell’ordine delle relazioni sociali, dei beni e dei debiti, e solo dopo rifondò la liturgia e donò la parola. Un messaggio di un valore immenso. Neemia fece l’assemblea in piazza perché quell’assemblea liturgica era già assemblea politica e sociale.
Le riforme religiose, liturgiche, ‘spirituali’ che non sono precedute da riforme economiche, finanziarie e sociali non sono soltanto inutili: sono estremamente dannose perché finiscono per dare un crisma sacrale alle ingiustizie, alle relazioni sociali sbagliate e ai soprusi.
Anche questo nostro giubileo non passerà invano se prima degli attraversamenti delle porte sante e delle indulgenze plenarie saremo capaci di nuovi patti sociali, di cancellare qualche debito, di liberare almeno uno schiavo, di ascoltare il grido delle donne e dei poveri. Ma, ad oggi, non sembra che questi atti giubilari siano all’ordine del giorno delle nostre comunità.