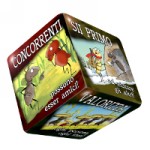Modelli - La filosofa politica canadese Jennifer Nedelsky sarà protagonista a maggio di un workshop accademico al Polo Lionello Bonfanti
di Luca Iacovone
pubblicato su Avvenire il 09/04/2025
«Quando tutto nella cultura odierna ci dice che la cura ha poco valore, è difficile credere che non sia tempo perso» osserva Jennifer Nedelsky, filosofa politica canadese, docente emerita alla Osgoode Hall Law School di Toronto e tra le pensatrici più autorevoli nel ripensamento del lavoro a partire dalla cura. Tocca uno dei nervi scoperti della nostra società: l’incapacità di riconoscere come prezioso ciò che non produce profitto. E la cura, al di fuori del cosiddetto “mercato della cura”, resta oggi spesso invisibile, svalutata, femminile.
Nedelsky non si limita a una critica teorica. La sua proposta, elaborata nel libro Part-Time for All: A Care Manifesto, scritto insieme a Tom Malleson e pubblicato da Oxford University Press, è radicale ma concreta: ridurre l’orario di lavoro retribuito a un massimo di 30 ore settimanali e riservare almeno 12 ore alla cura gratuita, condivisa, diffusa.
«La nostra proposta non è solo quella di valorizzare la cura pagandola di più. È quella di aumentare la quantità di cura non retribuita, perché tutti possano farne esperienza».
Non si tratta di un’utopia astratta, ma di un ribaltamento culturale necessario. In un mondo che misura il valore in termini di efficienza e produzione, la cura viene ancora percepita come un’attività secondaria, un compito domestico, un obbligo emotivo. «Io stessa — ammette Nedelsky — faccio ancora fatica a credere che occuparmi della casa sia importante quanto il mio lavoro accademico». Eppure, è proprio da lì che potrebbe partire una nuova economia delle relazioni.
Per Jennifer Nedelsky, la cura non è solo un’attività da valorizzare: è un’esperienza che cambia chi la vive. Non solo chi la riceve, ma anche chi la esercita. «La pratica attiva della cura permette alle persone di sperimentare come la cura costruisca relazioni, e come le relazioni abbiano bisogno di cura», spiega. È un processo di maturazione, che sviluppa capacità essenziali per la convivenza civile: l’umiltà, l’empatia, la capacità di mettersi nei panni degli altri. «Nel libro sosteniamo che le persone imparano l’umiltà e la capacità di assumere il punto di vista altrui proprio perché sono necessarie per offrire una buona cura. E questa è una competenza vitale per la democrazia».
In un tempo in cui il potere politico ed economico appare sempre più distante dalla vita quotidiana delle persone, Nedelsky denuncia un vuoto esperienziale prima ancora che valoriale. «Oggi la maggior parte dei politici è semplicemente ignorante riguardo l’importanza, le soddisfazioni e le esigenze della cura. Questo li rende pessimi decisori politici in quasi tutti gli ambiti: dai trasporti alla sanità, fino all’organizzazione del lavoro».
Per questo, la sua proposta non è solo sociale o economica: è anche profondamente politica.
La cura non è solo un dovere morale, ma una pratica di cittadinanza adulta, un esercizio di responsabilità condivisa da cui può dipendere la qualità della democrazia. Se chi governa non ha mai prestato attenzione a un bambino, assistito un genitore malato, curato un anziano, come può comprendere davvero le politiche che toccano il cuore della vita quotidiana?»
L’analisi di Jennifer Nedelsky non si ferma alla sfera relazionale. Perché la cura possa diventare una dimensione reale della vita quotidiana, servono cambiamenti strutturali nell’organizzazione del lavoro e dell’economia.
«Sono particolarmente interessata a unire la riflessione sulla proprietà delle imprese produttive - ad esempio attraverso la creazione di cooperative - con l’integrazione del tempo per la cura», afferma. È una visione che supera la classica dicotomia tra capitale e lavoro, e invita a considerare l’intera filiera del valore, comprese le comunità locali e l’ambiente naturale. «Abbiamo bisogno di nuove forme di proprietà che permettano ai lavoratori di avere voce nei luoghi di lavoro e di beneficiare direttamente della propria produttività. E abbiamo bisogno di modelli che tengano conto delle comunità locali e dell’impatto, anche sul mondo non umano, della produzione».
Quello che Nedelsky propone è un vero cambio di paradigma. Non si tratta solo di redistribuire il tempo, ma di ridisegnare le strutture economiche in modo che rendano possibile e desiderabile un altro stile di vita, fondato sulla reciprocità e non solo sulla prestazione. È un invito ad allargare lo sguardo, e con esso le categorie con cui interpretiamo l’economia: oltre il Pil, oltre la produttività, oltre il mercato. Alla domanda su quale potrebbe essere una piccola utopia realizzabile nei prossimi dieci anni, Jennifer Nedelsky non esita a rispondere con una visione lucida e sorprendentemente concreta. « Immagino una comunità dove beni e servizi siano forniti da imprese cooperative, nelle quali le decisioni vengono prese non solo da chi ha investito capitali o da chi lavora, ma anche da rappresentanti della comunità locale e da figure incaricate di valutare l’impatto delle attività produttive sugli altri esseri umani e sul mondo più che umano».
In questa visione i livelli di consumo sono più bassi rispetto a quelli dell’attuale classe media-alta, ma il consumo perde il suo valore simbolico: non è più uno strumento di distinzione sociale. « Lo status - continua Nedelsky - non deriverebbe dal possesso, ma dal tipo di cura che si esercita, oltre che dal contributo materiale alla produzione ». Tutti, in questa società, fanno parte di comunità di cura in cui si assumono responsabilità reciproche nel tempo. Un sistema fiscale equo garantisce i fondi necessari per i servizi pubblici essenziali — sanità, istruzione, trasporti — e per l’assistenza alle persone con disabilità. Non sorprende che Jennifer Nedelsky sia da anni una figura di riferimento per The Economy of Francesco, il movimento globale di giovani economisti, imprenditori, ricercatori e changemaker nato nel 2019 su invito di Papa Francesco per ripensare l’economia alla luce della giustizia sociale, della sostenibilità e del bene comune. È stata una delle prime voci autorevoli a credere nel progetto, accompagnando fin dai primi passi il villaggio tematico “Work and Care”, in cui giovani da tutto il mondo riflettono insieme sulla trasformazione del lavoro e sul ruolo cruciale della cura nelle nostre società. «Il villaggio Work and Care ha permesso di far emergere il legame profondo tra lavoro e cura, che troppo spesso restano separati», afferma.
Un legame che oggi, nel pieno della transizione tecnologica e della crisi del welfare, chiede di essere esplorato con coraggio e concretezza. Proprio per questo, il prossimo 2 e 3 maggio, Nedelsky sarà di nuovo in Italia per il workshop “Giving Care – (A) Time of Economic Change, Starting from Work”, ospitato al Polo Lionello Bonfanti a Figline e Incisa Valdarno, Firenze. Sarà un’occasione di dialogo, formazione e cocreazione aperta a studenti, studiosi, attivisti, imprenditori e a tutti coloro che stanno cercando nuove strade per riconciliare cura e produzione, comunità e impresa.