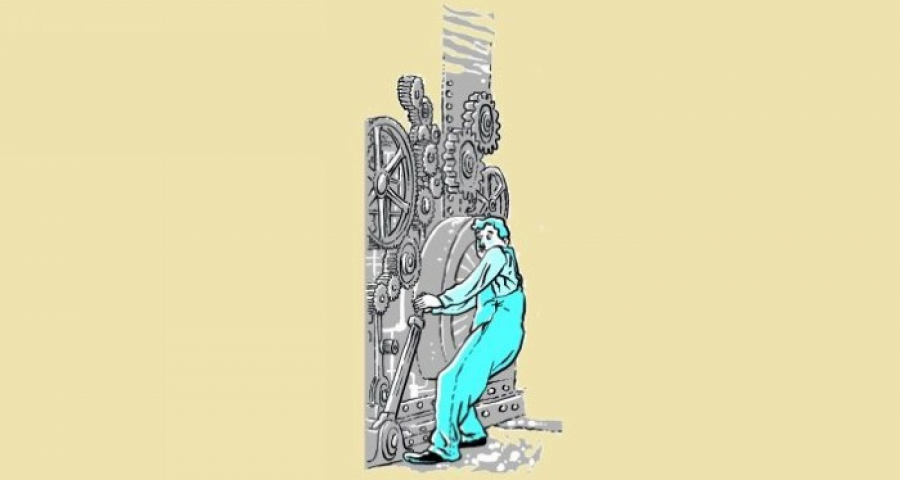Se vogliamo avere un rapporto giusto con il lavoro dobbiamo ricordarci che prima sono l’uomo e la donna a nobilitare il lavoro con la loro presenza, con le loro mani e con la loro intelligenza.
di Luigino Bruni
pubblicato su Il Messaggero di Sant'Antonio il 06/07/2023
Le crisi ambientali, finanziarie e militari di questo inizio di millennio, talmente gravi da non poter essere ignorate, rischiano però di farci sottovalutare o dimenticare una triplice crisi di cui si parla troppo poco: la crisi della fede, delle grandi narrative e del generare. Un mondo che non attende più il paradiso, che ha dimenticato le narrative collettive e che non mette al mondo figli, non trova più un sufficiente senso per vivere e quindi per lavorare. Le cosiddette «grandi dimissioni» di milioni di lavoratori, giovani e di mezza età, che lasciano il lavoro senza averne un altro, hanno certamente molte ragioni, ma una sta diventando quella dominante. È la mancata risposta a una domanda cruciale: «Perché dovrei lavorare, se non spero più in una terra promessa (sopra o sotto il cielo), se non ho nessuno che dal mio lavoro spera in un presente e un futuro migliori?».
Non dobbiamo mai dimenticare che il mondo del lavoro non ha mai creato né esaurito il senso del lavoro. Il lavoro è un pezzo importante del senso della vita, ma non lo esaurisce, c’è bisogno di qualcos’altro, oltre al lavoro, per vivere bene, anche quando il lavoro è bellissimo e ci appaga profondamente. Ieri questo «qualcos’altro» erano la famiglia, le ideologie, la religione, che davano al lavoro il suo giusto senso. Poi la fabbrica, i campi o l’ufficio rafforzavano quel senso che però nasceva fuori dal lavoro. Si lavorava bene perché prima e dopo del lavoro c’erano cose e persone più grandi del lavoro. Il lavoro era ed è grande, ma per essere visto nella sua vera grandezza deve essere guardato da fuori, da una porta o una finestra che si apre sull’esterno del luogo di lavoro; perché senza questo spazio più largo che prepara e segue il lavoro, la stanza del lavoro è troppo piccola, il tetto della fabbrica o dell’ufficio è troppo basso affinché quell’animale malato d’infinito che è l’homo sapiens possa restarci bene senza asfissiare, e possa restarci a lungo.
La nostra Costituzione è fondata sul lavoro perché il lavoro era fondato su qualcos’altro, era fondato sulla vita. Se le madri e i padri costituenti non fossero stati convinti che il lavoro era solo una parte della vita, che era quella zona mezzana tra un prima e un dopo, non avrebbe mai scritto quell’Articolo 1; perché fondare la costituzione su un lavoro che non si fonda su altro, sarebbe stata l’eresia etica più grande. Anche perché in quel qualcosa che precede e segue il lavoro ci sono i bambini che non lavorano perché non devono lavorare, i vecchi che non lavorano più, chi non ha potuto lavorare o non lavorerà mai perché la vita glielo impedisce. Fondare la democrazia sul lavoro è buono solo se ci ricordiamo che la parola lavoro è seconda, non è parola prima.
Il lavoro nobilita l’uomo, è vero. Lavorare ci fa migliori, e aumenta la dignità della vita e del denaro che ci serve per vivere, perché il denaro-salario diventa espressione di quella reciprocità civile che è il cemento buono della società. Ma se vogliamo avere un rapporto giusto con il lavoro dobbiamo ricordarci che prima sono l’uomo e la donna a nobilitare il lavoro con la loro presenza, con le loro mani e con la loro intelligenza. Perché se una attività, che potrebbe essere svolta da una macchina è invece svolta da una persona umana libera, questa persona dona maggiore dignità a quel gesto – a una lezione universitaria, a una visita medica, a un’opera d’arte –. E allora tutte le volte che espelliamo lavoratori e inseriamo macchine, stiamo riducendo la dignità di quel luogo di lavoro. È il nostro lavoro che aumenta la dignità della terra.
Credits foto: © Giuliano Dinon / Archivio MSA