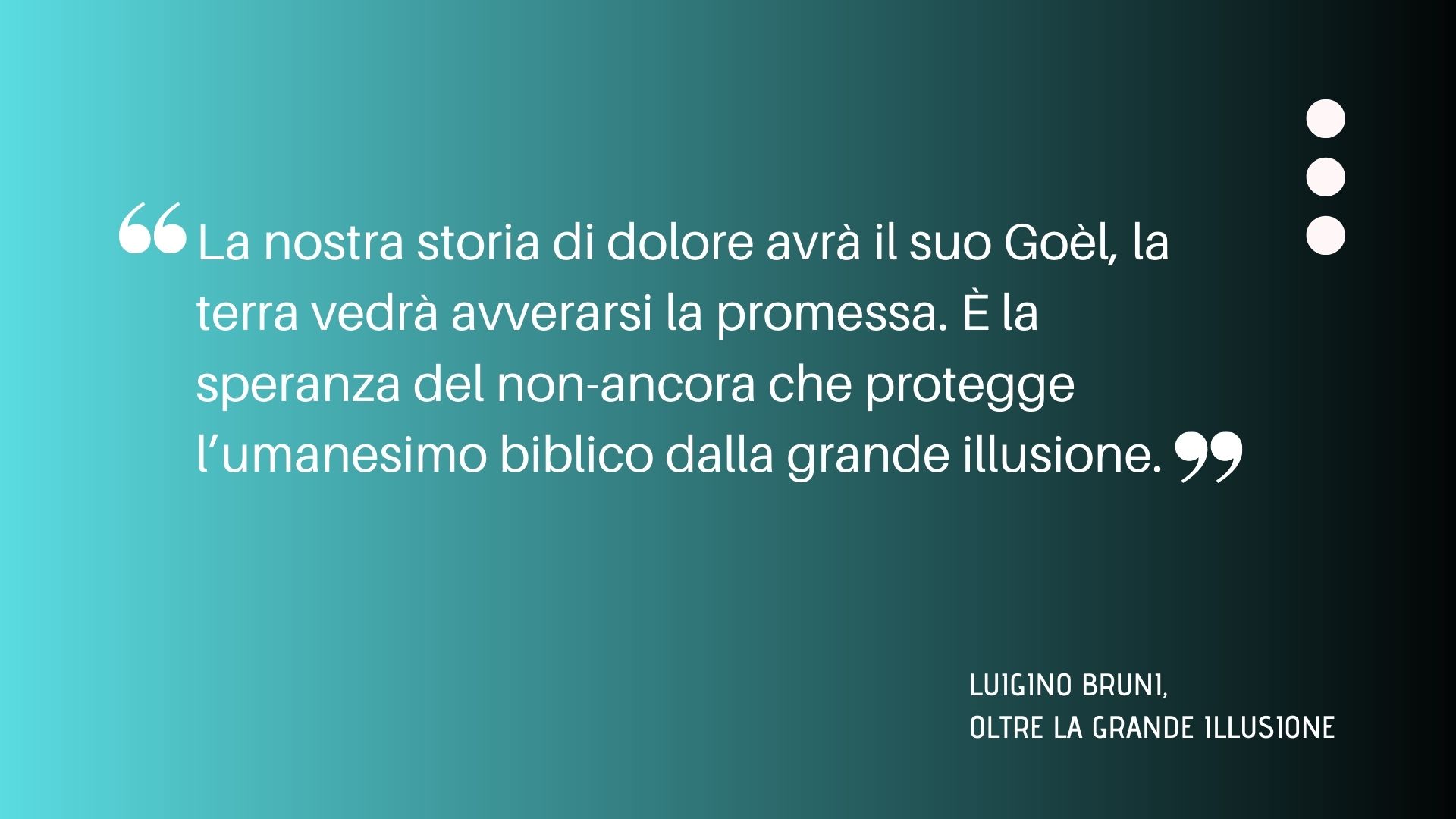Il mistero rivelato/15 - In ogni rapporto fallito si può ricominciare nel “nome” dell’altro
di Luigino Bruni
Pubblicato su Avvenire il 10/07/2022
"Abbiamo vissuto in fenditure della storia: ci diede riparo ciò che non chiude, totalmente, mai. Per l’ultimo giorno volevamo le visioni di cui ci siamo nutriti nell’esilio".
Ernst Bloch A Ingeborg Bachmann, dopo la sua visita al ghetto di Roma
La profezia consegnata a Daniele della fine dell’esilio, che non è arrivata ma arriverà è il fondamento biblico della grande virtù della speranza. E aiuta a interpretare il tempo.
Nei patti, l’essenziale è la fede nella fedeltà dell’altro. È più fondamentale della nostra propria fedeltà. Un patto spezzato può sperare di risorgere se, e fino a quando, chi ha tradito crede che l’altra parte è ancora fedele, spera che dall’altro capo della corda che ci lega e che io ho mollato ci sia una mano forte che tiene ancora. Tutto finisce davvero quando dall’altro capo della corda non c’è più nessuno – o quando crediamo che sia così. Nella Bibbia la fede in Dio è la speranza che da qualche parte nel cielo ci sia una roccia salda che non ci fa sprofondare dentro le nostre infedeltà. Da qui nasce la preghiera più bella che si può alzare dalle crisi della fede e dei nostri rapporti primari: «Tu, almeno tu, non mollare; resisti, continua a credere in quel patto che io, per fragilità o colpa, non sono stato capace di custodire. Sii fedele anche per me». In latino corda, fede e fiducia sono la stessa parola: fides.
«Nell’anno primo di Dario (...) io, Daniele, tentavo di comprendere nei libri il numero degli anni di cui il Signore [YHWH] aveva parlato al profeta Geremia e che si dovevano compiere per le rovine di Gerusalemme, cioè settant’anni» (Daniele 9,1-2). Nel libro di Daniele entra Geremia, un profeta vissuto alla vigilia dell’esilio babilonese, che aveva profetizzato: «Tutta questa regione sarà distrutta e desolata e queste genti serviranno il re di Babilonia per settanta anni» (Ger 25,11). Una profezia di durata che ha fatto lavorare molto i rabbini e gli esegeti antichi e moderni. Siamo più o meno dentro i settant’anni profetizzati da Geremia se iniziamo a contare gli anni dell’esilio dalla distruzione del tempio di Gerusalemme (il 587) e fissiamo la sua fine nella ricostruzione del tempio (il 516). Ma – e questo è quanto più preme ai profeti – quando l’autore del libro di Daniele scriveva (II secolo a.C.) il suo popolo viveva dentro un altro "esilio" e si chiedeva: fino a quando? Per sperare non bastava ricordare la verità della fine del primo esilio di Babilonia, era necessario che la fine di quel grande esilio diventasse la caparra per la fine dell’oppressione di Antioco IV Epifane. Perché quando si vive una grande crisi il ricordo delle liberazioni del passato aumenta solo la sofferenza del presente, a meno che quell’antica storia non diventi risorsa per rinascere ora. Nessun passato ricordato salva se non diventa risorsa per liberare il presente e generare un futuro buono. Senza questa dinamica passato-presente-futuro, con il suo fulcro sul presente, non capiamo né la profezia né la Bibbia. Da qui la domanda di Daniele: cosa dice a noi quell’antica profezia di Geremia sulla fine dell’esilio mentre oggi in un altro esilio speriamo e attendiamo una liberazione che non arriva?
Questa domanda crea l’ambiente per la grande preghiera di Daniele, uno dei brani più belli e profondi del suo libro. Prima però Daniele ci dona anche un insegnamento sulla preparazione alla preghiera: «Allora volsi la mia faccia verso il Signore Dio alla ricerca di un responso con preghiera e suppliche, con il digiuno, veste di sacco e cenere e feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore, mio Dio» (9,3-4). Innanzitutto lo sguardo: volsi la mia faccia al Signore. Orientai gli occhi, guardai oltre me, forse verso Gerusalemme. Pregare è cambiare sguardo, è imparare a guardare diversamente. La preghiera biblica non inizia guardando dentro in cerca del proprio vero io o della propria interiorità profonda – una ricerca quasi sempre vana perché non fa altro che aumentare quell’io che si vorrebbe ridurre: è anche questa la trascendenza del Dio biblico. Alla preghiera ci si prepara invece guardando fuori, cercando un altrove. Non si comincia chiudendo gli occhi, ma aprendoli per guardare fuori di noi e più lontano. La preghiera biblica è estroversa, è un ribaltamento dell’anima indigente in cerca di una luce che arriva da fuori e che poi scompare lasciandoci di nuovo mendicanti di luce e di cielo. Dobbiamo ringraziare ogni giorno la Bibbia per averci custodito questo sguardo infinito e questa linea su un orizzonte più profondo perché svuotato dai nostri idoli materiali e spirituali, che ha consentito, in un altro giorno, di vedere l’infinito dentro un sepolcro di nuovo vuoto.
Continua la lettura su Avvenire.