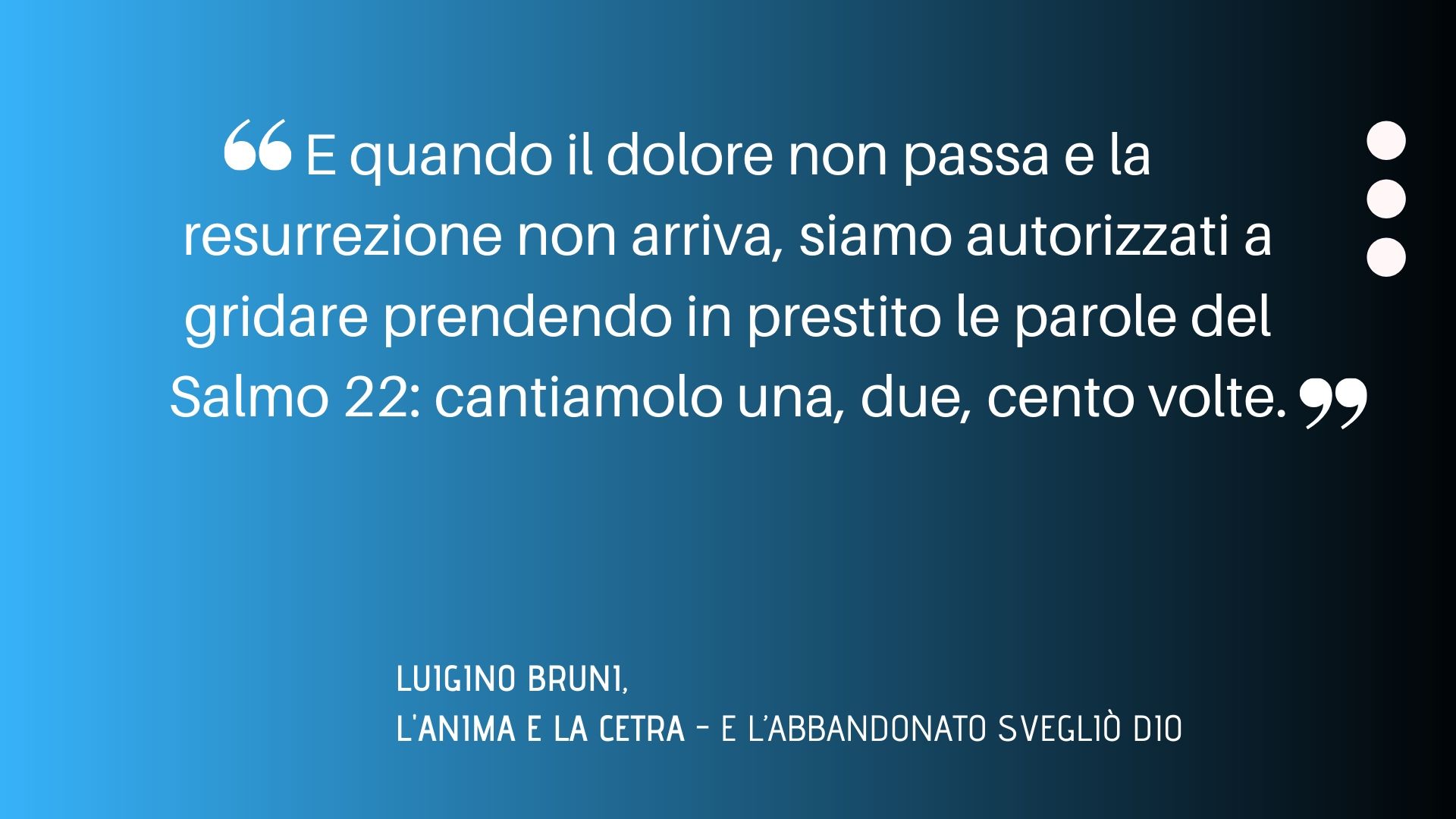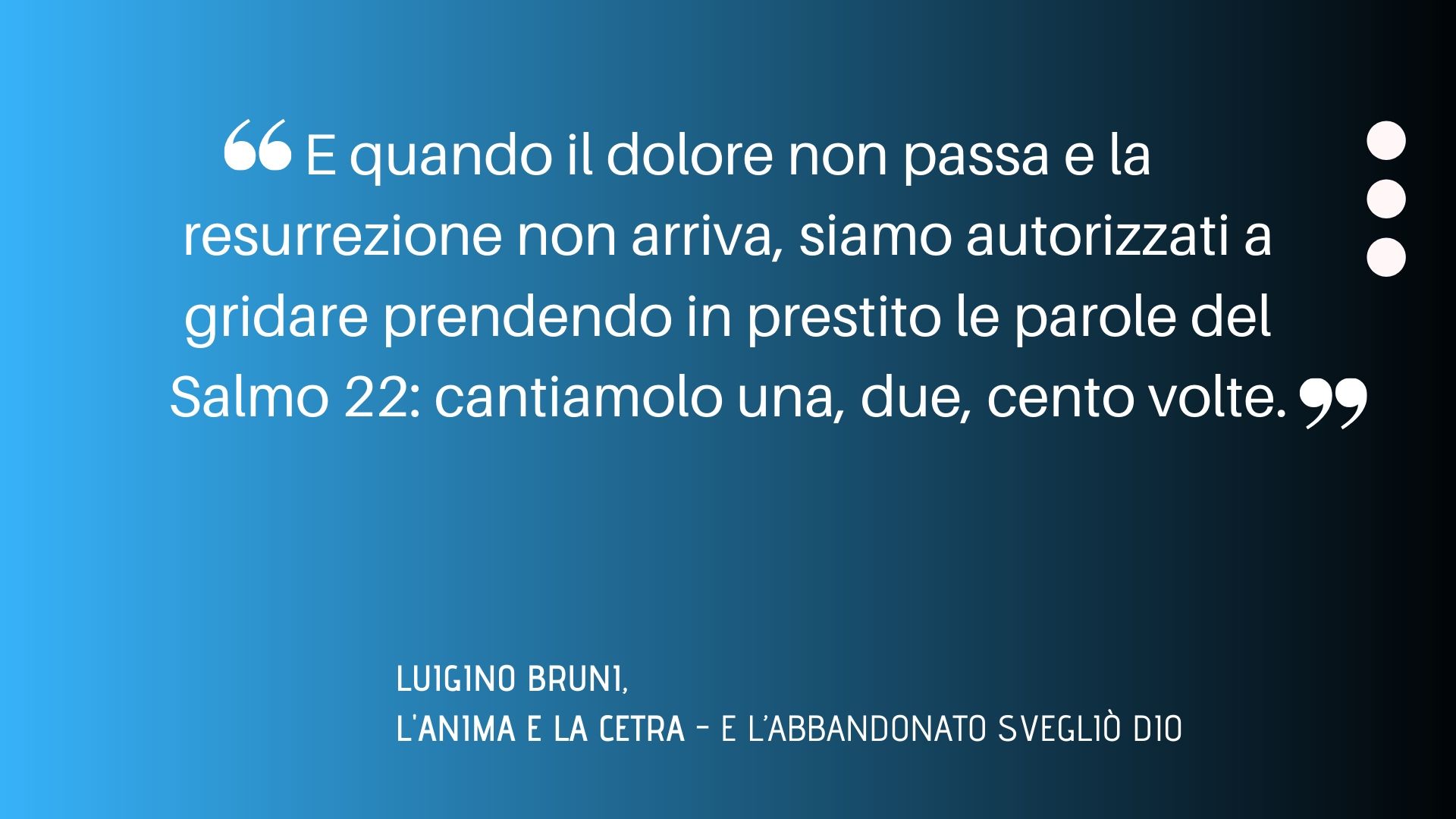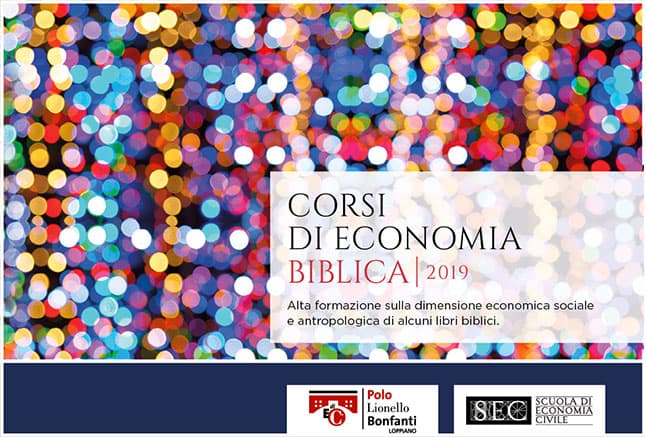L’anima e la cetra/12 - Il Signore sta dalla parte della liberazione non della condanna
di Luigino Bruni
Pubblicato su Avvenire il 14/06/2020
"Urlate, urlate, urlate! Oh, siete fatti di sasso! Se avessi io le vostre lingue e i vostri occhi, li userei in maniera che la volta del cielo si squarcerebbe"
William Shakespeare, Re Lear
Il Salmo 22, una delle vette poetiche e spirituali della Bibbia, è anche il pentagramma su cui è stata scritta la sinfonia della passione di Cristo. E ci aiuta a comprendere qualcosa dei crocifissi e del loro mistero.
Un uomo è perseguitato, torturato, umiliato, disprezzato da altri uomini. Sente la morte molto vicina. Quell’uomo è innocente – come tanti altri, ieri e oggi. Sa di non meritare quel grande dolore, quella violenza, quelle umiliazioni – e chi le merita? Ma quell’uomo, oltre a essere un giusto sofferente e umiliato, è anche un uomo di fede. E lì, in quella notte buissima, forse in un carcere, sopra un mucchio di spazzatura o dentro una cisterna, nasce una preghiera, gli affiora nell’anima un ultimo canto disperato. Che inizia con parole che vanno incluse tra le più preziose, tremende e stupende della Bibbia, tra le più tremende e stupende della vita: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Salmo 22,1). Una vetta poetica, spirituale e antropologica del Salterio, forse quella più alta.
Ancora un grido che apre una preghiera, come in Egitto, quando la prima preghiera collettiva del popolo schiavo fu un altro grido (Esodo 2,23). Molte preghiere grandi prendono la forma del grido, di un urlo scagliato verso il cielo per cercare di svegliare Dio. Nella Bibbia gridare è possibile, lecito, consigliato, è un linguaggio che Dio sembra capire. Urlando possiamo destare Dio, ricordargli il suo "mestiere" di liberatore di schiavi e di poveri. Finché siamo capaci di gridare l’abbandono non abbiamo perso la fede, la stiamo solo esercitando, la stiamo semplicemente compiendo.
Quell’uomo torturato, quel "servo sofferente" grida e vive la sua sventura nella fede, e quindi dentro quell’abbandono sente anche l’abbandono di Dio. E quel grido diventa la corda (fides in latino) per non perdere contatto con Dio, il filo d’oro della vita che non si spezza proprio perché osiamo gridare. Quell’uomo non accusa Dio di averlo ridotto in quelle condizioni; diversamente da Giobbe, non considera Dio il suo carnefice. Il suo dolore nasce invece dal non intervento di Dio, che dovrebbe intervenire come liberatore del suo fedele innocente, ma ancora non lo fa: «Mia salvezza, perché sei lontano? Non parlo più, muggisco» (22,2).
Continua la lettura su Avvenire.